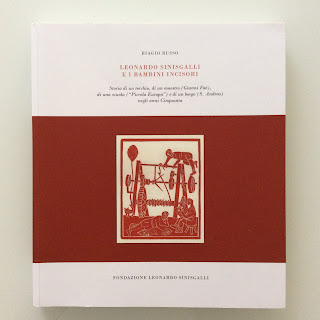“La musica è il piacere che la mente umana prova quando conta senza essere conscia di contare” (Leibniz), “La poesia è una prolungata esitazione fra il suono e il senso” (Valery): fra le più belle definizioni di queste due arti sorelle, le suddette vanno tenute in conto per l’esame della poesia di Maria Grazia Insinga, che pesca nella faglia tra numero e parola per rintracciare le dis/armonie del visibile e dell’udibile. Figure che affiorano dal fondo, armonici che emanano dal puro suono.
L’essenziale asemanticità della musica può infatti farci cogliere fremiti, “movimenti furtivi del corpo o della coscienza, inaccessibili all’espressione verbale”. Il vissuto in presa diretta. L’impulso sotteso alla rappresentazione. Se nella poesia le parole e le frasi consuete si piegano ai principi del metro e della paranomasia per costituire un unico flusso ritmico-semantico, al contrario in musica è il flusso sonoro a costituire “figure” e “frasi” nel corso di una esecuzione. Poesia e musica appaiono perciò per molti aspetti complementari. Di questa loro reciprocità essenziale può avvalersi al meglio il poeta che sia anche musico in senso pieno, cioè che sappia leggere ed eseguire una partitura musicale. Questo è il caso di Maria Grazia Insinga che compone all’incrocio dei due linguaggi e delle due tradizioni, inventando nell’infimo spazio di gioco fra suono e senso, scavando dentro questa cesura intima (Riss) per abbozzare il profilo (Umriss) della parola-corpo. Lo fa a diversi livelli e regioni della catena dell’essere, dall’individuo all’ambiente, al cosmo, scoprendovi strati nascosti e continenti sommersi; ricomponendo geografia e orografia, memoria e storia, leggenda e mito, in una unica suggestiva sussurrata archeologia mediterranea: Tirrenide, che intreccia un ideale dialogo con l’Atlantide platonica, arricchendo la trama dei possibili rimandi, la polifonia del testo poetico, componendo una sinfonia dell’esserci nella varietà delle pieghe del linguaggio. Poeticamente, musicalmente, indaga nei tagli minimi tra vita e forma, tra essere e coscienza, riuscendo così a conferire un nuovo respiro al progetto della poesia in quanto tale.
Insinga cerca insomma di recuperare il senso pieno del luogo dove vive e fare della sua terra un mondo dagli infiniti echi, mostrandoci tangibilmente come il suono, “l’assoluto non verbale”, possa farsi strada nel cuore della parola e sedurla verso l’innominabile. E come reciprocamente esso possa annidarsi nelle pieghe del discorso e convertirsi alla passione della parola, cioè alla verifica del senso, al sacrificio dell’indicibile al dicibile. Perciò ella evoca la varietà timbrica che attraversa i nostri corpi e lascia traccia nelle condensazioni e nei traslati onirici, facendone simbolo di un continente sommerso: Tirrenide è una allegoria quanto mai attuale di questa ambigua e incompiuta rivelazione. Sicché il suono vi accade come lacerazione delle figure del discorso in cui si innesta, come seme di una mutazione incipiente, sostrato del senso che affiora nelle sue intime pieghe, nei ritmi variati e nelle pause calcolate dei versi, nelle appena accennate dissonanze che ci avvertono che qui si tratta di quella musica del Novecento che corre sul filo fra distonia e silenzio. Ma si percepisce specialmente in questa poesia la consuetudine (forse improvvisamente interrotta) con uno strumento, il pianoforte, che filtra nella discontinuità della sua tastiera il continuo sonoro del mondo, in una dialettica proficua fra continuo e discreto, così come fra legato e staccato, un gioco di pedale difficilmente percepibile dai non addetti ai lavori. E tuttavia il testo nel suo insieme possiede una cristallina chiarezza, una forma nitida e una cadenza orecchiabile: ma il filtro strumentale del pianoforte ne sottende e orienta tutti i procedimenti poetici, coniugando il controllo e l’abbandono, l’entusiasmo e la tecnica, in una sapiente e suggestiva traduzione sillabica della materia sonora. E quindi qui si tratta di un’esperienza al limite, di una offerta e una sfida reciproca per la composizione e per l’ascolto.
Tirrenide è un’opera in sei sezioni asimmetriche, versi e strofe irregolari, con abbondanza di eserghi e assenza di punteggiatura, eccetto qualche raro punto interrogativo. Inizia con una sestina che reca il titolo “dizionario verdiano” e costituisce una parodia atonale della ouverture in quanto forma sia operistica che sinfonica. In essa incontriamo subito l’ossimoro della “voce muta”, che sta nel contempo per voce trattenuta nel corpo (“voce-corpo”) e voce che muta precipitando “di un’ottava sola”, rovinando “in un dirupo liquido”. Immediatamente appaiono dunque la figura retorica e l’opposizione paradigmatica, solido/liquido, terra/mare, che caratterizzeranno l’intero poema, messe a tema in controcanto seriale, con la ripetizione finale “piano piano” che si può bene intendere come una indicazione agogica: “muta di voce di pensiero muta/ di corpo voce muta voce corpo/ voce e muta voce e precipitasti/ di un’ottava sola e rovinasti in/ dirupo liquido e rovina e muta/ voce muta il terzo piano piano. (8)
Così esplicitamente, anzitutto attraverso la permutazione insistita dei due termini dell’ossimoro “voce muta” su una ideale scala cromatica di dodici note, si attua la ricreazione verbale di un pensiero musicale immanente al testo. Già dalla lettura di questo primo lacerto della “voce corpo” si possono afferrare dunque il tenore e la portata della invenzione poetica di Insinga, nonché la finezza della tessitura armonica sottesa al dramma dello sprofondamento del corpo della voce (genitivo soggettivo e oggettivo) nella liquidità ritmica e fisiologica che la sottende, e si espande poi quasi naturalmente nella orografia ed ecologia mitiche di un continente sonoro sommerso, sotteso alla produzione di senso nel linguaggio verbale. E più in generale alla costituzione dell’accordo elementare o del simbolo (in un qualsiasi linguaggio) attraverso cui si possa poi esprimere l’emergenza di una singola forma di vita o di coscienza. Si tratta dunque di un’operazione radicale sul suono e sul senso, nel discorso in versi, quasi un equivalente di quel miracolo di ricreazione musicale in prosa che è il capitolo di “Sirene” nell’Ulisse di Joyce.
Non si potrà certo seguire in dettaglio tale reciproca trasfigurazione di cellule semantiche e musicali, nell’ambito di una recensione e neanche di un breve saggio. Ci si dovrà perciò accontentare di esempi e lacerti che supportino il quadro ermeneutico delineato e il difficile orientamento dell’ascolto. Perché è un bilinguismo sapido e anfibio, voce e carne di sirena, quello che regge questa incredibile s/composizione di luogo nel linguaggio verbale, coinvolgendo terre e mari, l’emerso e l’immerso, il maschio e la femmina, i vivi e i morti, tutti evocati nel dialogo a distanza fra un pianoforte inceppato e un corno magico. In uno spazio tensorio che, come suggerisce Devicienti nella sua bella postfazione, evoca curvature gravitazionali e salti quantici, benché solo per analogia e alla lontana. Certo Maria Grazia Insinga è poeta colta, vigile e attenta, che mette poeticamente a frutto quello che sa del mondo. Ma ciò che davvero caratterizza il suo dettato è il dialogo competente e sorvegliato, benché vissuto in prima persona e sulla propria carne, fra il verbale e il musicale. Al di là di ogni pur suggestiva analogia, qui si tratta del tentativo consapevole di una ardua, reciproca trasposizione tra versi e frasi musicali, nello spazio minimo e incolmabile tra senso e suono, tra figura e fondo, tra la geografia delle terre emerse e la mitica Tirrenide. Un progetto peraltro perspicuamente riassunto nell’esergo della seconda strofa: “sotto una lingua a rullarne un’altra/ scava intere città cammina sull’acqua” (9)
Così al pianoforte muto, per qualche guasto o per un trauma subito dal suo esecutore, fa riscontro il “corno magico”, simbolo di fertilità nelle antiche religioni e connesso in Grecia alla potenza del canto di Apollo che sfida la legge del tempo uniforme, astrale, dettata da Crono o Saturno: cioè risolve in musica i decreti del cielo. Mi piace leggerlo così questo richiamo al corno che evoca l’emersione delle specie dal mare, facendo da ponte modulante fra l’acqua e l’aria: prende “a cornate l’aria l’aria vince”, (10) portando agli uccelli il canto della balena, costituendo un vertiginoso riepilogo di traiettorie evolutive all’interno delle modulazioni seriali delle parole e dei sintagmi verbali. E che a me ricorda in particolare il trio per corno, pianoforte e violino di Ligeti, dove il suono dello strumento a fiato, più vicino al respiro umano, media proprio la tensione fra il continuo degli archi e il discreto delle percussioni.
Questo è solo un esempio di ciò che è sotteso alle parole e ai versi in questo testo, dove il dubbio e la predizione, l’esitazione e la scelta dell’esserci vengono evocati in una “lezione di scetticismo” svolta di nuovo in controcanto atonale col severo modo ipodorico, proprio della musica greca antica, con la variazione insistita sulla parola “dopo”, che conferisce una inflessione ironica a ogni tentazione escatologica: “e tanto diremo è tuttodopo/ora e non saremo e mai” (10). Perché “tutto è nuovo” in questa musica da bere che inghiotte parole e cose sul filo del rumore bianco come in una unica radiazione cosmica di fondo. In questo ponte fra suono e senso si innesta subito un riferimento esplicito (“tutta quella musica per una malatesta/e quella poesia per una malagrazia/l’idioma nascosto è pioggia oro”: 12) a un’opera di un compositore siciliano che funge come da specchio a questa di Maria Grazia Insinga. Un’opera dove la parola tenta proprio di riaffiorare a nuovo, in una sorta di palingenesi, emergendo dal suono stento, come il conato di una forma di vita nei cicli evolutivi, sull’orlo del silenzio, sull’abisso del buio. Si tratta di Mie luci traditrici (dramma vocale strumentale in due atti, musica e libretto di Salvatore Sciarrino, che verte sulla traduzione musicale del tradimento della parola data nel vincolo del matrimonio): perché quei “malatesta” e “malagrazia” che incontriamo in epigrafe di questa strofa, costituiscono un preciso rimando agli ominosi “Malaspina”, protagonisti del dramma del compositore palermitano. Dove quello della latenza del senso nel suono, del suo stentato pervenire alla parola e all’accordo, cioè della difficoltà della enunciazione sia verbale che musicale, costituisce il tema portante e il principio strutturale dell’intera composizione. Questo preciso rimando non indica però affatto una somiglianza nei procedimenti compositivi di Insinga e di Sciarrino, quanto piuttosto la loro significativa complementarità, la specularità dei loro percorsi dal suono alla parola e viceversa. In bilico entrambi sull’abisso del silenzio e sul buio che sottendono la trasmissione della parola e l’inganno dello sguardo.
Un conato che diviene del resto esplicito (nella strofa seguente) in quel “corpo fonema”, in quel “precipitarsi” della parola-corpo nel “dirupo fonetico” sul filo del grecale che alimenta l’incendio appiccato nella macchia mediterranea (su una sponda del tirreno che ben conosco), fra terra e mare, dove calma la mano del poeta “corregge la linea del fuoco”. (13) Tirrenide: la casa sottosopra della veggente palombara, tuffatrice, sirena, scandaglio e diapason di questo mare di segni e di suoni. In una logica arcaica, preumana, “non binaria”, musicale e biologicamente neutra, in un linguaggio “privato e privativo”, che esula da ogni politica di genere, andando molto più a fondo, fino a indagare il transessuale delle pietre e dei fiori: orchis, “orchidea e testicolo”. Linguaggio della mescola dei vini e dei colori nostrani: vin santo, inzolia, cataratto; spremiture di colori e di timbri, in un rito quasi eucaristico che ci porge l’ostia purificata dell’isola: “soffice santa pantelleria tutta oro colato”. (13-15) Una s/parizione nel silenzio minerale, dove pure può scorgersi qualche crepa, perché le pietre hanno “momenti di debolezza” (16) e cedono al ronzio animale dell’orto in un mondo aurale (mero suono) dove non c’è niente da decifrare e di cui la poesia è la carne, il poeta il carnefice. E ancora più indietro verso il cataclisma della sparizione del suono, del ritrarsi nel silenzio di un primo tempo e spazio insufficienti, dove la stessa fine di qualcosa (chissà, forse l’ascolto musicale), si risolve ossimoricamente e umoristicamente in una risata muta. In un dialogo primordiale che la poesia tiene con la musica che la sottende e che rimane precluso ai critici letterari e alle loro “dediche inopportune” (17).
E’ in questo luogo arcano che si svolge lo smembramento rituale (sparagmos) della voce e la teofania della sirena che getta la propria ombra monca di braccia e dita sullo spazio anfibio tra la costa orlandina e il mar tirreno, sul confine eolico della “iancura”. In questo orizzonte apocalittico, “mentre gli emisferi /ribollono fino all’artico”, il sacrificio estremo del corpo-voce tenta di raccogliere e dire poeticamente (léghein, logos) la catastrofe ambientale nella cavità orale, “sul farsi del nulla sul farsi del verso”, (19) dove si fondono “acqua luce fuoco o buio” e si compie lo sfinirsi di ogni figura, la regressione verso l’infanzia della parola, la caduta libera del senso nella evanescenza del suono, la confusione delle forme nel diafano della luce. In uno sviluppo dove ondulatorio e corpuscolare, melodico e percussivo, continuo e discreto si alternano e si integrano a vicenda in quel continente sommerso (Tirrenide) che non potrà di fatto mai più riaffiorare.
E’ in questo orizzonte eolico (sul filo di iancura) che si svolge il dialogo ancestrale fra il sé e l’altra, la donna e la sirena, la poeta e la musicista, due facce della stessa medaglia: inverse e incompatibili, profili complementari che appaiono come in un esperimento subatomico, quello che la parola tenta di intavolare con la musica che la sottende e dove la solida materia verbale si risolve in fugaci accordi e pure frequenze, s/comparse di onde sonore o luminose: fremiti e vibrazioni dell’esserci. In questo orizzonte ominoso, compare prepotente “idda” (21), teofania di Ligheia, quella Sirena che ha stregato per sempre il professor “La Ciura” nel racconto eponimo di Lampedusa. Epifania dell’Altra (intima e perturbante) cui espressamente non è accordata alcuna dedica in questo testo, ma il cui fantasma ubiquo sempre aleggia, ibrido fra la sirena e l’uroboro (“le dita di serpentessa lungo pendici/ vesuviane fino ‘a muntagna miele” (21): il drago primordiale che si morde la coda, simbolo complesso dell’eterno ritorno di ciò che è perturbante ma che qui rappresenta anche lo disseminazione rituale del canto antico della sirena nelle volute del verso: la scomposizione del suono che presiede alla donazione di senso nell’atto di parola. Uno smembramento che poi si precisa come “amputazione della mano”, una sorta di pegno pagato per quel dono della veggenza poetica che fa tutt’uno con la consapevolezza di essere sempre in ritardo sugli eventi e incapaci di coglierne appieno il senso: “sul far del verso eravamo in ritardo/ lì lì per non essere in tempo in ritardo/ inevitabilmente e dunque dunque” (21). Si tratta perciò qui di una vera e propria imputazione del talento poetico all’amputazione della mano che suona il pianoforte, nell’alternarsi di battere e levare, di anticipo e ritardo, in quel minimo fuori tempo che ci sospende sul nulla. In questa intima onirica alterità, l’impotenza delle mani fa tutt’uno con l’efficacia della parola e dell’immagine poetica che ne costituiscono il supplemento - al limite fra sogno e veglia, sul ciglio-fiore (ophyris) del discorso, sull’orizzonte diafano della iancura: “lei è ancora sonno/ la compressione dei nervi il formicolio lei/ alle mani… non potenza” (39). Così la mano amputata e inerte, sacrificata, si può considerare la parte “male-detta”, la sineddoche portante di questa mirabile trasposizione verbale di armonie e fughe musicali, sottese e impedite, o solo affioranti nei tagli di correnti equoree che vengono dal fondo, disegnando labili figure in superficie. Tra il sonno e la veglia, tra ripetizione e differenza, nel corso discontinuo del tempo, dove è futile nominare gli eventi, affiora a tratti il continente sommerso della musica sulla superficie della parola: in un dramma filogenetico oltre che esistenziale, dove l’altra dorme in un altrove liquido mentre la terra si fa più deserta.
L’alter ego della poeta, la sirena che le dorme in petto, “nel sogno non decifrabile” (41) si precisa così nella ferita intima e nel contorno effimero di un’unica figura: l’altra è il fiore dell’acqua, ophirys, l’orchidea/orchide, il sopracciglio, il limine, il supplemento, lo svolazzo primordiale, la firma a margine di queste pagine, la sigla di quel patto po-etico, di quella presunzione di senso richiesta dal discorso in versi e accordata dal lettore, ma fino a un certo punto. Questo senso della misura metrico-morale è un altro tratto saliente della poetica di Maria Grazia Insinga, che non chiede mai quell’apertura di credito in bianco che altri poeti pretendono in virtù del loro essere “musici” (mistici, orfici, sperimentali). E benché ella sloghi all’occorrenza la sintassi verbale in funzione dell’effetto inteso, non arriva mai a torcerle il collo, non la sacrifica in nome di una arcana musicalità ma piuttosto fa interagire i due linguaggi in parallelo, attraverso la costruzione di serie armoniche che attraversano lo sviluppo tematico del testo, secondo frequenze variate che vanno ben al di là della misura dei versi o delle strofe. Ella tenta insomma di estendere musicalmente la variazione ritmica a tutte le dimensioni e i parametri del testo, come accade in buona parte della musica colta del Novecento, creando un continuo verbale allargato di flussi e riflussi, sprofondamenti e affioramenti, in un dramma che è musicale, appunto, ma nel contempo geologico ed ecologico: Tirrenide.
In questo orizzonte archetipico si proietta il dramma intimo, l’agone del corpo-voce e della sua caduta nell’indecifrabile onirico musicale. Un movimento che si incrocia con quello inverso della mutilazione della mano della pianista cosmica, che la costringe a rivolgersi alla parola e a stravolgerla poeticamente dal suo interno, seguendo le correnti e le esondazioni improvvise (“lei incurante esonda”: 40) del mare onirico musicale dove ancora vive l’altra che la abita, la Sirena dal canto insostenibile. L’inseparabile sorella che la attira sul fondo, in una casa preclusa agli umani, nella spirale del tempo (“corno completamente vuoto”: 41), nell’immemoriale del sonno e del mare, congiunte solo dall’inconcepibile ponte modulante del sogno, in quanto passaggio formale da una sezione all’altra del vissuto planetario. E tutto ciò sul ciglio dell’abisso, sul limine e sul supplemento della parola, Ophyris (fiore del discorso e ciglio del volto della sirena). (43) Nell’intimità del frammezzo, dello stacco (Schied), della di-afferenza terracquea reciproca (Unter-Schied) che nell’esserci ambiguo della Sirena fa la “recreazione” del mondo in quest’opera, come la concepisce la sua autrice. Sulla soglia dell’udibile che ora si manifesta anche come orizzonte del visibile: “iancura”, la luce biancoceleste eolica, il limite quasi impercettibile, sfumato fra cielo e mare in una giornata di bonaccia. Margini e tagli d’orizzonte che perimetrano questa ricapitolazione onirica della genesi del vivente fra mare e terra, che fa tutt’uno con l’invenzione della parola poetica sul fondo ritmico-musicale, quel “sovrappiù di armonici” (44) che sottende la scansione dei versi e che fa sì che essi non possano essere segmentati alla maniera solita ma che piuttosto debbano essere ingoiati interi come in un atto di cannibalismo, nel sacrificio arcano del discreto del linguaggio al continuo musicale che lo pretende dal suo fondo. Perché “la voce e il libro sono la stessa cosa/ma la voce preesiste nella coesistenza” (45) Così, di passaggio, in questa metamorfosi marina della parola, può anche leggersi una dichiarazione di poetica. Perché qui, dove non si “distingue la fine dall’inizio la destra da sinistra” (45), sulla soglia del visibile appare la figura della Sirena (fusa con quella del serpente primordiale, simbolo di tutti i cicli) aspide mutilata delle mani, che compone sillabe in accenti e pause, scrivendo “la lallazione del tempo” sul limine del bianco celeste mutismo, nella iancura dove si intravvedono le Isole Eolie dalla costa tirrenica, da quella sua Capo d’Orlando che assume le fattezze di un “punto cieco di non ritorno”, per la voce poetica che scaturisce dai confini della terra (Finisterrea: 27).
Insinga trasfigura così la propria vicenda e la propria dimora in un orizzonte archetipico dove si svolge il dramma dello sprofondamento del linguaggio verbale sul suo fondo musicale. Dove il “pensiero piatto” cede ciclicamente alla “evoluzione di strutture sottomarine” (45). Dove il poema si consuma nel “flutto oceanico del ventre suo” (49) in un disordine anfibio, sui cui margini di spuma si svolge questo trasumanante dramma in versi, “tra voce primaria e secondaria” che farebbero “profonda/ perfetta coincidenza…se non ci fosse il tempo” che induce sfasamento tra le battute, tensione ritmico-melodica nell’unità poetica dell’esserci. “Il tempo grande scultore” (50) che pietrifica la musica nella parola agita e sillabata, in quel dialogo poetico-musicale che ora si conclude in un finale aperto, una sorta di naufragio con spettatore dove al calare delle notti, nello sfinimento dei giorni, quasi non ci si accorge neppure che questa “progressione armonica…di strutture sottomarine” (45), “diluvio e rovina e numero” (47), opera di “mala grazia” (51) è finita, o quasi. Che sta per concludersi insomma il dramma congiunto di corpo, voce e sguardo, dimezzati, anfibi e per ciò stesso veggenti. Mentre le due “divise invise” (52) facce dell’io poetico, l’una all’altra segrete, tuttavia aspirano all’intero (54): a una arcana, provvisoria congiunzione dell’esserci e dell’epoca, all’ecpirosi, al miracolo di una rigenerazione congiunta per aria e per fuoco.
Giuseppe Martella