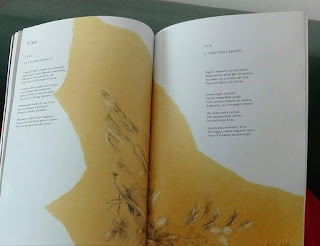Segno e materia. Se si guarda alla medesima giacitura sul piano semantico di queste due parole, qualcosa stride, non sono i due volti di una stessa medaglia. Sono due campi con polarità che si respingono, che acclamano per sé soli il centro della scena. Molto più del connubio significante/significato o forma/contenuto, visto che in tali coppie l'uno viene tratteggiato con le caratteristiche dell'altro (e non a caso la categoria che le accoglie è l'arte): il significato di un oggetto artistico sarebbe inestricabile dalla particolare forma da cui, per l'appunto, si trae.
Ora ritorniamo ai nostri 'segno' e 'materia' che così prepotentemente si fronteggiano quando si stiano osservando le opere di Gianluca Murasecchi (che è possibile vedere nella mostra "Da Segno a Segno" presso la galleria Edieuropa a Roma, fino al 5 luglio 2017, in cui Murasecchi espone insieme a Guido Strazza). Persino quando si affrontino le incisioni a bulino su carta, non ci si può fermare al consueto riferimento cartaceo, mettendolo subito in sordina, perché il segno stesso s'incarica, qui, di trasferire il significato nuovamente alla carta, alla sua tessitura fibrosa, in quanto l'oggetto visivo è un fascio di linee lussureggianti, indicanti la tridimensionalità spaziale: fluenti e vivissime mostrano, fin dove il loro accavallarsi consente visibilità, i sovrapposti incroci, facendoci trarre il concetto di spazio proprio in conseguenza del loro sovrapporsi non su piani susseguenti, ma in una rete.
A volte maggiormente esplicito, Murasecchi, nei suoi inchiostri, parte da frammenti di tessuto dislocati sul foglio e, con abilità concettuale tutta esheriana, coi suddetti fili, dal loro ordine ortogonale, ricava un groviglio che genera un vero e proprio caos, e che vede il suo ritorno all'ordine ricostituendosi all'interno di un altro frammento di tessuto disegnato in un altro punto del foglio. Il filo/segno, cioè, non ha inizio né fine. Il caos è qualcosa che è sempre sotto il nostro sguardo: è nella cosa, è nella carta, è nella materia tutta. Allo stesso modo dell'ordine che appare semplicemente come un cambio di passo.
Un diverso regime di aggregazione indicato mai riservando allo spazio un ruolo solamente accessorio e sempre negando la bidimensionalità del foglio. Ciò non vuol dire affatto, dunque, che materia e segno coincidano, ma che coesistono due letture incompossibili (come quella che riguarda massa ed energia). Nelle acqueforti vediamo una griglia che campisce la totalità dello spazio: il segno vi si espande come se fosse costitutivo della materia intera ed è ancora una tessitura quella che si dispiega infinitamente, abbia essa l'aspetto di una linea che si arrotola costantemente su se stessa o una garza che su di sé ripieghi.
La geometria vi fa un ingresso trionfale: la quadratura del cerchio è data dalle approssimazioni che l'occhio istituisce vedendo un profilo preciso persino lì dove non si tratta altro che di tessiture sovrapposte che ispessiscono annerendo. Straordinari effetti setosi di garze adagiate su altre producono in controluce fenomeni distortivi, vere e proprie attrazioni magnetiche che ricordano gli studi di Faraday.
La materia mostra la sua irriducibilità al segno. Agisce per motilità propria, determina un'azione di disturbo, deviazione, oppure produce aggregazioni ordinate, ma in ogni caso il segno s'incarica di rendere evidenti i passaggi da uno stato all'altro; ci avviciniamo, pertanto, al nucleo che ci premeva mettere in luce: vediamo la materia solo attraverso i segni, ma la materia determina il comportamento del segno.
Introduzione necessaria per affrontare i lavori in cui Murasecchi interviene su supporti innovativi: il polistirene o il polistirene fuso sul quale l'artista opera con pigmento oleominerale e catrame, il che ci indirizza anzitutto verso un Murasecchi artefice tellurico, sperimentatore inesausto in una fucina artistica non lontana da quella alchemico-scientifica: lo testimoniano, ancora una volta, gli oggetti delle sue figurazioni, tutte ascrivibili a un immaginario scientifico, geologico, molecolare.
In ogni caso, il ricorso a nuovi materiali come il polistirene, materiale compatto, ma friabile, costituito da minuti granuli, che già Dubuffet negli anni Settanta aveva scolpito, conquistato dalla facilità della lavorazione, consente di abbandonare l'immediato riferimento al dato naturale e d'inerpicarsi in una dimensione maggiormente astratta e concettuale. Il polistirene, disponibile ad approcci con la fusione e con l'acidatura, è duttilmente utilizzabile in calcografia, scultura e pittura e, finito con smalti che ne aumentano la resistenza agli agenti atmosferici e alla luce, si mostra particolarmente adatto a rivestire superfici o elementi ferrosi, come i chiodi che tatuano alcune superfici di opere presenti nella mostra.
Incidere questi leggeri elementi volumetrici, massi di cartapesta verrebbe voglia di dire, trattare le superfici che ricevono, come tavolette di cera, la traccia del passaggio di fluidi elettromagnetici, mostrando solchi, bordi, rilievi, e ancora rotture della superficie con il rilievo geometrico dei punti (in orbita o disposti lungo griglie regolari) oppure lo slabbro interno, l'apertura sul caos nel dialogo perenne tra i diversi stati della materia, ci fa credere che geometria nemmeno esisterebbe senza un dialogo col mondo informe.
Tuttavia, vogliamo specificare che non vi è un trapasso inerte di scala tra arte bidimensionale e scultura, in quanto la ricerca attuata da Murasecchi trae dall'effettiva tridimensionalità della scultura un'ulteriore direzione di ricerca che include la penetrazione del segno all'interno di un volume: un segno volumetrico a tutti gli effetti.
Per Gianluca Murasecchi ciò che sta sulla superficie è solo un effetto ottico, uno stato liminare, un'interpretazione del visibile del tutto casuale. Il segno, probabilmente non è che una proiezione mentale tutta umana, ma anche ciò che dà forma e apparenza al mondo. La materia senza segno non appartiene al mondo dell'arte, ma nemmeno il segno potrebbe essere prodotto senza la materia. Materia e segno sono in disgiunzione perenne, ma Murasecchi riesce a fissare il calco del loro incontro.
Rosa Pierno
Il 5 luglio 2017 alle ore 19 Lea Mattarella incontra Guido Strazza e Gianluca Murasecchi presso la galleria Edieuropa, Piazza Cenci 56, Roma